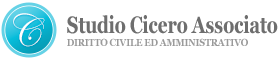A. Forchielli* & M. Boldrin, Il Sole 24 ore, 3 IX 2025
LA CRISI POLITICA FRANCESE E IL FANTASMA ITALIANO
La crisi politica francese non si spiega soltanto con le dinamiche partitiche o con la personalità di Emmanuel Macron. E il risultato di fattori strutturali, ignorati o sottovalutati per decenni, che oggi esplodono in forma di instabilità istituzionale. Non scomparirà di certo con le dimissioni di Bayrou e nemmeno se Macron venisse sostituito da Le Pen o da un altro esponente della destra francese alle prossime elezioni presidenziali.
Il dato di partenza è semplice: il debito pubblico francese ha superato il 110% del PIL (114,2% nel 2024 Secondo Eurostat), con una spesa primaria che da anni eccede stabilmente il 55% del PIL. Tra le principali voci di rigidità figurano la spesa pensionistica (circa il 14% del PIL, seconda solo all’Italia nella UE) e l’ampio comparto assistenziale e sanitario. In parallelo, la pressione fiscale ha raggiunto il 44% del PIL, seguita da Italia, Danimarca e Belgio. Come in questi altri paesi non sembrano esistere margini per aumentarla ulteriormente senza effetti depressivi sulla base imponibile e sulla competitività del paese. In questo contesto, il “realismo tecnocratico” di Macron e del suo governo ha tentato di introdurre correttivi minimi: la riforma delle pensioni, innalzando l’età legale da 62 a 64 anni; il contenimento di alcune voci di spesa; un’insistenza costante sulla necessità di avviare riforme per preservare la sostenibilità finanziaria. Tuttavia, queste scelte si scontrano con gli interessi di gruppi sociali largamente maggioritari.
In Francia il 28% della popolazione ha più di 60 anni (dati INSEE 2023) e i beneficiari netti della spesa pubblica superano ampiamente i contribuenti netti. Non sorprende che ogni ipotesi di riforma mobiliti vaste proteste, che vengono strumentalizzate sia dalla sinistra – difesa integrale dello Stato sociale – sia dalla destra – difesa corporativa delle categorie protette. Se vi ricorda un altro paese che conoscete vuol dire che siete abbastanza fisionomisti.
L’analogia con l’Italia è infatti immediata. Nel 1992 la crisi valutaria e di bilancio mise fine alla Prima Repubblica: i mercati imposero una correzione drastica, la lira fu svalutata, si introdusse una patrimoniale (il famoso prelievo forzoso del 6 per mille) e si avviarono privatizzazioni.
Nel 2011, sotto la pressione dello spread oltre i 500 punti base e di un debito al 120% del PIL, il governo Berlusconi cadde lasciando spazio all’esperimento tecnocratico di Mario Monti. In entrambi i casi, la politica tradizionale fu incapace di gestire il vincolo esterno e si rifugiò in soluzioni d’emergenza.
Ma quelle soluzioni, come dimostra la traiettoria successiva, non hanno risolto i problemi strutturali. I problemi strutturali si risolvono solo quando sono riconosciuti tali dalla maggioranza dell’elettorato e questo esprime una forza politica capace di farsene carico. Una tale forza in Italia non esiste e il tentativo di Macron di costruirne una in Francia sembra destinato a esaurirsi presto. Vale la pena notare che oggi l’Italia non è in condizioni molto diverse dalla Francia. Il nostro debito è al 137% del PIL, la spesa pensionistica al 16,3% del PIL (dati Eurostat 2023), la pressione fiscale al 43,5%, la spesa pubblica sopra il 48%. L’economia cresce poco o nulla: dal 2000 al 2023 il PIL pro capite italiano è aumentato di appena il 2,7%, contro il 15% della Francia e il 25% della Germania. A differenza della Francia, tuttavia, l’Italia ha già da tempo accettato questa condizione di stagnazione.
Non si riforma, non cresce, ma convive con il debito attraverso continue ricomposizioni politiche e compromessi sociali. I salari stagnano, a volte persino flettono, ma gli aumenti nel numero di occupati – accompagnati da un ulteriore calo della produttività – sembrano compensare questi dati negativi agli occhi dell’opinione pubblica. La miseria diffusa, evidentemente, non allarma, anzi rallegra: mal comune, mezzo gaudio.
La borghesia produttiva francese, soprattutto quella legata all’industria e all’export, non ha ancora metabolizzato l’idea del declino. Si oppone, protesta, chiede che il paese resti competitivo. D’altro canto, i gruppi sociali sussidiati in una forma o l’altra dall’intervento pubblico si oppongono a ogni cambiamento e lo scontro sociale causa l’instabilità politica a cui stiamo assistendo. In Italia, invece, il ceto produttivo ha imparato a sopravvivere nella bassa crescita: esporta quando può, evade o elude quando necessario, si adatta alla contraddizione fra alta pressione fiscale e spesa pubblica inefficiente, raccoglie bonus quando spunta l’occasione. La borghesia produttiva italiana sembra aver accettato l’assenza di crescita, ma la temporanea pace sociale così ottenuta non è detto possa continuare ancora a lungo.
La crisi politica francese è dunque uno specchio che ci rimanda la nostra immagine di dieci o quindici anni fa.
La differenza è che l’Italia ha scelto la rassegnazione, mentre in Francia lo scontro è ancora aperto. Resta da vedere se la reazione francese produrrà un aggiustamento vero o se, come accaduto a noi, si risolverà in un lento accomodamento al declino.
§ § § § – § § § §
* Nella prima di copertina del suo libro “Il potere è noioso“, scritto con Michele Mengoli, Alberto Forchielli viene definito come “il più anarchico degli economisti” (Nota dello Studio)